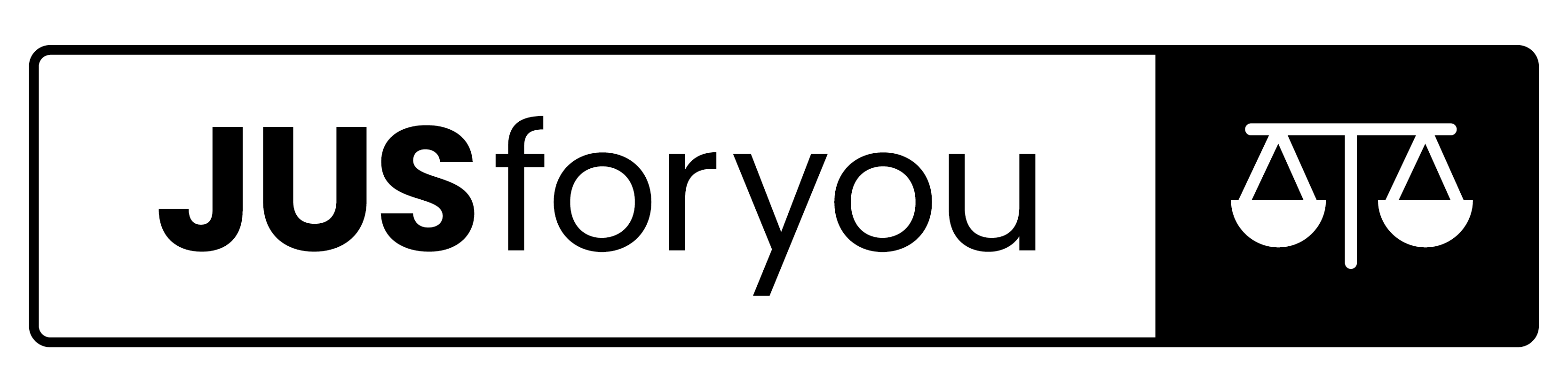Cass. Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 9442
La Convenzione di Merida, utilizzando il verbo “mantain”, obbliga gli Stati contraenti, nel processo di progressiva attuazione degli obiettivi di tutela perseguiti, a impegnarsi a preservare gli standard di tutela raggiunti e, dunque, dall’astenersi dall’adottare misure, legislative o amministrative, che comportino il regresso rispetto al livello di attuazione raggiunto nel perseguimento degli scopi della Convenzione.
Questo obbligo non comporta che le norme penali interne necessarie a garantire l’obiettivo debbano rimanere cristallizzate al livello più rigoroso che hanno attinto (e non esclude in radice la riduzione delle aree di illiceità penale o, persino, l’esclusione del ricorso alla sanzione penale), ma attribuisce alle norme attuative una particolare “forza di resistenza” all’abrogazione, che le sottrae a novazioni legislative non conformi al vincolo posto dalla Convenzione.
L’abrogazione del reato di abuso di ufficio ha violato questo specifico obbligo, in quanto non è stata “compensata” dall’adozione di meccanismi, preventivi o repressivi, penali o amministrativi volti a mantenere il medesimo standard di efficacia ed effettività nella prevenzione degli abusi funzionali intenzionalmente posti in essere dagli agenti pubblici ai danni dei cittadini.
Il legislatore, invero, abrogando l’art. 323 cod. pen., ha fatto cessare la “close conformity” con l’obiettivo posto dall’art. 7, quarto comma, della Convenzione di Merida e ha violato l’obbligo di mantenere fermo, nella propria legislazione, il livello di efficacia nella prevenzione della legalità dell’azione amministrativa contro gli abusi di ufficio stabilito in sede convenzionale.
Nell’ordinamento penale non vi è, infatti, alcuna norma che consente di sanzionare l’esercizio arbitrario di una funzione pubblica, con prevaricazione a danno “degli altrui diritti”, se il fatto non è commesso con violenza o minaccia (concussione) o a fronte della promessa o della dazione di un corrispettivo illecito (corruzione).
L’abrogazione del reato di abuso di ufficio, lungi dal bilanciare tra le esigenze costituzionali dell’imparzialità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante l’ulteriore riduzione dell’ambito dell’incriminazione, ha dato prevalenza incondizionata all’autonomia di amministratori e funzionari nell’esercizio della funzione pubbliche, sacrificando integralmente la tutela dei cittadini contro gli abusi posti in essere dai pubblici agenti intenzionalmente ai loro danni.
Il deficit rispetto agli obiettivi di tutela fissati dagli artt. 19 e 7, quarto comma, della Convenzione di Merida, conseguente all’abolizione del reato di abuso di ufficio, del resto, non è stato colmato dell’art. 9, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, che, a decorrere dal 5 luglio 2024, ha introdotto nel codice penale il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili all’art. 314-bis.
Questa fattispecie di reato riferendosi ai c.d. abusi di ufficio distrattivi, si colloca fuori dal perimetro applicativo dell’art. 19 e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 17 della Convenzione, dedicato alla “sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficial: la Corte costituzionale, nella sentenza n. 8 del 2022, ha rilevato che le esigenze costituzionali di tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione non si esauriscono, nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni: l’incriminazione costituisce anzi un’extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o l’inadeguatezza di altri mezzi di tutela.
Il legislatore, tuttavia, nell’abrogare il reato di abuso di ufficio, non ha correlativamente rafforzato il livello di prevenzione, a livello amministrativo, contro le condotte abusive e la violazione dell’imparzialità da parte dei pubblici agenti in danno dei privati, come imposto dagli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione di Merida.
Il legislatore, nell’abrogare il reato di abuso di ufficio, ha considerato l’idoneità delle disciplina amministrativa vigente a tutelare l’interesse pubblico e non già quello dei cittadini a non essere danneggiati dagli abusi funzionali o dalla mancata astensione dei pubblici agenti che agiscono in conflitto di interesse.
La previsione del reato di abuso di ufficio, con riferimento alla violazione dell’obbligo di astensione e al divieto di violazioni della legge poste in essere intenzionalmente in danno del privato, aveva, infatti, una portata generale ed estremamente efficace, anche sul piano preventivo, in ragione della previsione della minaccia della sanzione penale.
I rimedi preventivi anticorruzione (quali quelli introdotti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), per loro natura, riguardano molto marginalmente i comportamenti dei singoli funzionari e si concentrano sull’organizzazione dell’azione complessiva dell’amministrazione, senza assumere alcun effetto specifico nei confronti della singola azione illecita.
I rimedi giurisdizionali, peraltro onerosi, non sempre non attivabili, in quanto, non di rado, le prevaricazioni dei pubblici agenti si traducono non in atti amministrativi, ma in meri comportamenti, come tali non impugnabili.
Parimenti frammentaria e non sempre coerente è la disciplina amministrativa dei conflitti di interesse; le sanzioni disciplinari per la violazione dell’obbligo di astensione previsto nei vari codici deontologici richiesti dall’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono, infatti, difficilmente applicabili ai dirigenti di più alto livello per i quali più che la responsabilità disciplinare vale quella di risultato, in forza dell’art. 21 dello stesso decreto, e non operano per gli amministratori eletti.
I sistemi disciplinari previsti dal diritto amministrativo sono, inoltre, estremamente frastagliati, in quanto sono calibrati dal legislatore sulle specifiche funzioni e sullo statuto che disciplina la singola figura di pubblico agente.
L’attivazione dei sistemi disciplinari è, inoltre, rimessa all’esclusiva denuncia del privato, che deve rivolgersi all’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale autore di condotte di abuso di ufficio (rispetto al quale il privato potrebbe trovarsi in condizioni di timore riverenziale); i procedimenti disciplinari sono, inoltre, dotati di poteri di istruttoria meno incisivi di quelli ammessi nel processo penale e non consentono l’intervento della persona offesa.
Parimenti la responsabilità contabile ed erariale non assicura una prevenzione efficace e adeguata degli abusi funzionali commessi in danno dei privati, in quanto questo sistema di responsabilità è incentrato sul danno arrecato allo Stato e non è attivabile a fronte di danni subiti meramente dal privato.
Il legislatore, dunque, nell’abrogare il reato di abuso di ufficio, non ha introdotto discipline amministrative che mantengano il pregresso standard di efficacia nella prevenzione dei conflitti di interesse e degli abusi di potere dei pubblici agenti prescritto dalla Convenzione di Merida.
Alla stregua dei rilievi che precedono, il Collegio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, d’ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l’art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.
![]() Cass. Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 9442
Cass. Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 9442